7
ca strada che ormai possiamo percorrere. Sta a noi che non diventi come minaccia di diventare, una
strada che proti al cimitero di tutta l’umanità.
Questa è una cosa che andava detta, perché sulla scia dei movimenti ecologisti (sacrosanti) si sta
creando tutta una pubblicistica popolare che invita a tornare alla natura, anzi alla Natura
rappresentandola come qualcosa di verde e arcaico, amica dell’uomo, sorridente e pronta a donare i
suoi frutti, con generosità. Non è vero. La natura è anche i ciclone, la siccità, le cavallette. Per vivere
naturalmente bisogna rompersi la schiena, è non è più neanche possibile farlo ormai. Siamo quattro
miliardi e mezzo, gente. Tra vent’anni saremo quasi il doppio. Qui se non si sfruttano a fondo le risorse
crepiamo tutti di fame. Altro che ritirarsi in campagna.
Quindi l’atteggiamento corretto è auspicare e combattere per raggiungere un mondo in cui le cose si
equilibrino. Vivere a contatto della natura rispettandola ma con le facilitazioni della tecnica. Con
l’industria che dia la precedenza alle cose fondamentali e non rapini il profitto a scapito anche del
proprio futuro. Senza il consumismo. Sena sovrapopolazione. Senza lo sfruttamento. Senza la guerra…
Nel 1944 Clifford Simak ebbe questa intuizione, nel suo racconto City dove la cosa avveniva
automaticamente, grazie alla tecnologia. Con la massima facilità di trasporto, il crollo, di valore dei
terreni non più legati alla loro posizione, l’automatismo nelle fabbriche, non c’era più ragione che la
gente vivesse e a lavorasse ammassata l’una sull’altra. In una parola non c’era motivo per cui
esistessero ancora le città. E così gradatamente le città sparirono lentamente, sempre più deserte e
lentamente ingoiate dalle proprie rovine.
Un’ipotesi suggestiva. Ma fattibile? Pensiamoci un momento. Oggi c’è il telefono televisivo. Si
possono trasmettere fotocopie, per telefono. Si possono comandare macchine a distanza. È veramente
necessario stare tutti assieme nello stesso edificio o in quanto a questo, nella stessa città per fare un
lavoro? Chiunque potrebbe lavorare restando a casa. Niente più ore di punta. Miliardi di ore lavorative
risparmiate sugli spostamenti e restituite alla vita.
Giustamente Simak faceva notare che il problema non è sociale, ma politico. Le forze conservatrici o
addirittura reazionarie che si opporrebbero in ogni modo a questa grossa rivoluzione sarebbero tutte
quelle che si fondano sull’organizzazione delle masse. E cioè le chiese, i trust, i governi i partiti, i
sindacati…Anche gli organismi progressisti si opporrebbero contro qualcosa che metterebbe in forse la
loro esistenza…Perché non esisterebbero più masse, ma individui. Qualunquisti se vogliamo. O al
contrario, se vogliamo anarchici. Comunque non manovrabili.
È piuttosto significativo che quando City uscì, venne considerata un’utopia “negativa”. L’idea di una
disseminazione di individui proprietari ciascuno di una casa e di un pezzo di terra e responsabili solo
davanti a se stessi è tanto rivoluzionaria da spaventare anche i rivoluzionari. Un miglioramento diverso
dalla direttive di sviluppo è “negativo”.
Comunque City, apparso sulla rivista Astounding ebbe tanto successo che Simak continuò sul tema.
In genere una serie di racconti nati per sfruttare il successo del primo è un prodotto bassamente
commerciale. Non con Simak. I suoi racconti formarono un tutto organico che nel 1952 poterono
diventare un libro dallo stesso titolo. City (edito in Italia con il titolo “Anni senza fine” raccontava
attraverso la saga della famiglia Webster la scomparsa dell’umanità dalla Terra, prima sostituita dai
cani e poi dalle formiche…Gli uomini vivono su Giove, dove hanno trovato la felicità e la piena
realizzazione di sé pagandolo con la perdita, anche fisica, dell’umanità. Erede della loro cultura è il
robot Jenkins, personaggio contuttore della saga e maggiordomo della famiglia Webster, essere (se mi è
permesso il bisticcio) umanissimo che diventerà guida spirituale della civiltà canina per poi sparire con
essa in un’altra dimensione.
In City c’è tutto Simak. C’è una storia intesa più come un prlbema esistenziale che una serie di
eventi: c’è la solitudine sociale dei protagonisti che non si traduce necessariamente in un solitudine
spirituale ed emotiva: c’è il suo rifiuto come dicevo non tanto della tecnologia quanto per l’uso che ne
viene fatto per opprimere quella che oggi viene chiamata “la qualità di vita”; c’è la valutazione positiva
dell’individuo che difende la propria individualità da una società livellatrice e ne nello stesso tempo
possiede una semplice ma autentica solida moralità. C’è la comprensione addirittura la simpatia per la
diversità: c’è l’amore per gli esseri viventi, qualunque essere.
4
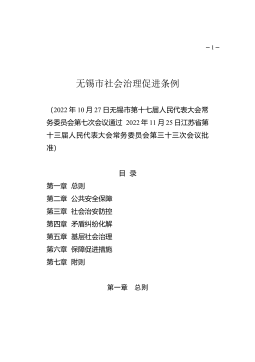
 2025-08-19 4
2025-08-19 4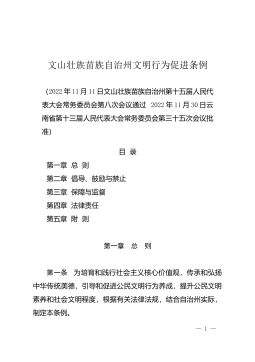
 2025-08-19 1
2025-08-19 1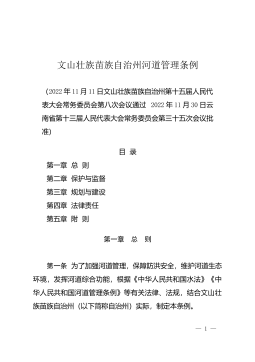
 2025-08-19 1
2025-08-19 1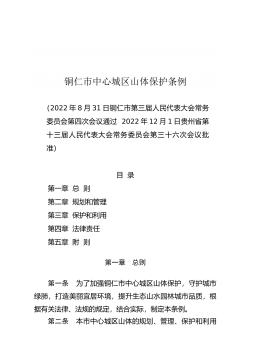
 2025-08-19 1
2025-08-19 1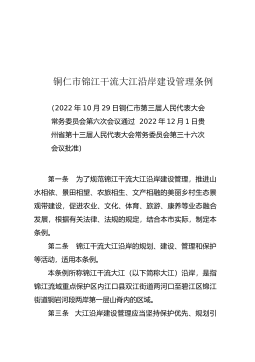
 2025-08-19 2
2025-08-19 2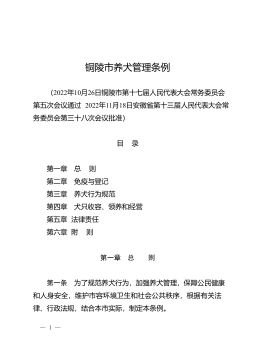
 2025-08-19 3
2025-08-19 3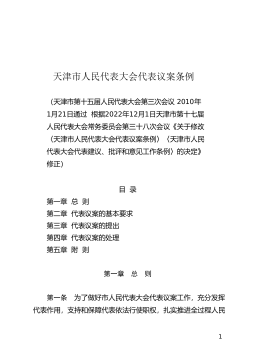
 2025-08-19 7
2025-08-19 7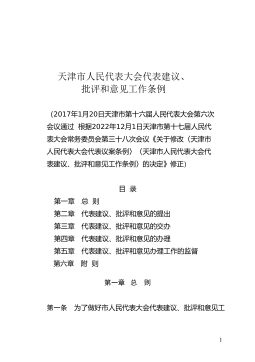
 2025-08-19 3
2025-08-19 3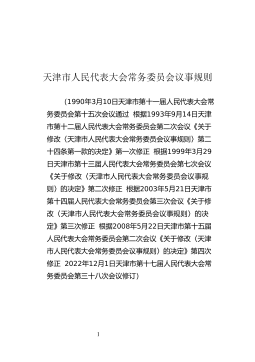
 2025-08-19 5
2025-08-19 5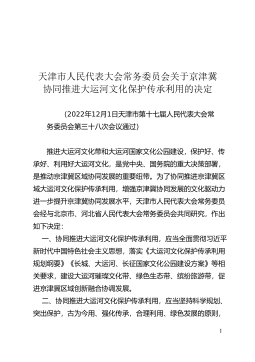
 2025-08-19 6
2025-08-19 6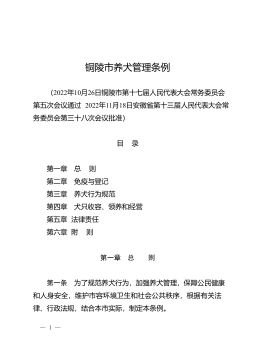
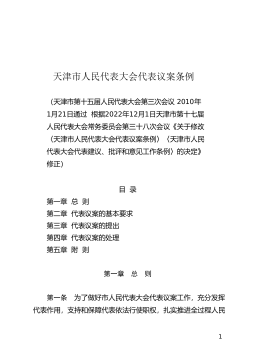
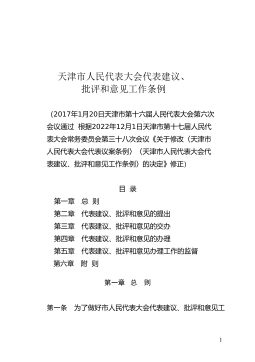
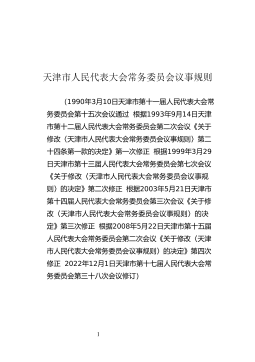
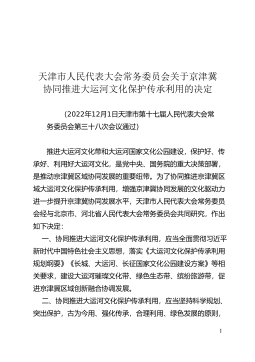


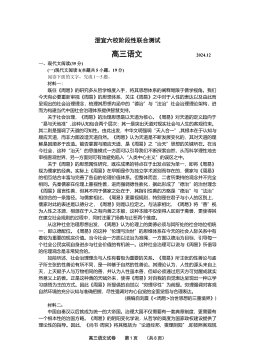

 渝公网安备50010702506394
渝公网安备50010702506394
